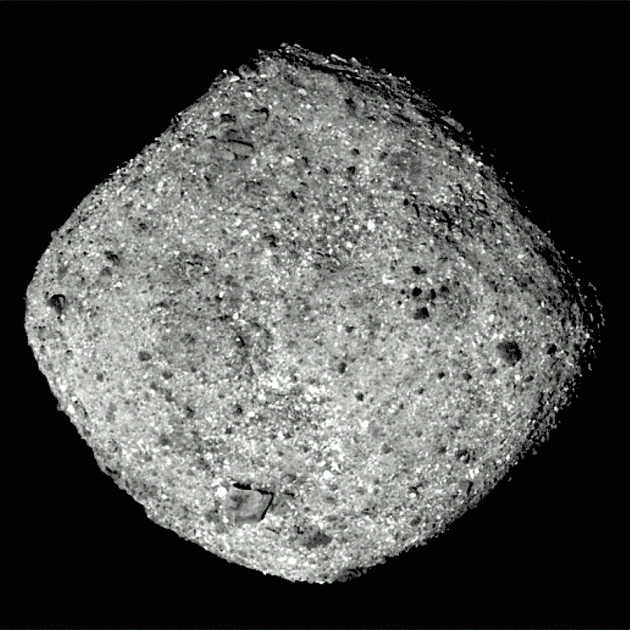Anni fa… mamma mia come vola il tempo, Ilmiolibro fece un contest partendo da un incipit di Paola Mastrocola. Non partecipai ma scrissi ugualmente il pezzo che vi sottopongo alla vostra benevolenza.

Siccome avevo preso un altro brutto voto, mio padre mi disse:
– Va bene, allora oggi verrai con me a lavorare. Così vedrai come si fatica!
Mio padre faceva il giardiniere, e andava in giro per i giardini altrui. Andava a potar piante, rastrellare foglie e tagliare erba col suo potente tagliaerba.
Quel giorno doveva occuparsi niente meno del giardino dei terribili Lorchitruci.
I Lorchitruci erano la famiglia più ricca e potente della collina. A me facevano paura due cose di loro: il nome, perché mi veniva da pensare a orchi molto truci; e il giardino, appunto, perché era chiuso da una muraglia gigantesca dietro la quale chissà che cosa mai si nascondeva.” (incipit di Paola Mastrocola su ilmiolibro.it)
Però ero curiosa di sapere cosa si nascondeva dietro quel muro. Mio padre c’era già stato, ma era sempre stato molto parco nel descrivere le abitudini delle persone alle quali accudiva i giardini.
Dunque oggi marinavo la scuola col suo consenso, ma questo non mi piaceva e non mi faceva gustare la giornata di libertà.
– Lavorare? – non ci pensavo nemmeno, perché ero sicura che non mi avrebbe fatto fare nulla.
La sveglia era stata alle sei anziché alle sette come al solito, ma sognavo di vedere sorgere il sole con il cielo rosato là in fondo e cupo sopra la mia testa. Questa mattina alcuni fiocchetti rosati solcavano il cielo come graziose navicelle, mentre di buon passo lo seguivo lungo il ripido sentiero che conduceva al giardino più impenetrabile della collina.
L’ululato sguaiato di due cani ci accolse da dietro l’enorme cancellata di ferro, che chiudeva la vista della villa. Un brivido di freddo, ma era paura, mi percorse la schiena. Per farmi coraggio mi dissi: – Non puoi avere paura! Sono solo due cani. –
Però un po’ di tremarella agitava le mie gambe, che avrebbero voluto correre giù lungo quel sentiero percorso con tanta baldanza.
Ero sempre stata una bambina vivace, impertinente e con poca voglia di applicarmi a scuola. La maestra, un donnone dalla circonferenza smisurata, diceva ai miei genitori attoniti e amareggiati: – È intelligente. Ha la mente sveglia. Sarebbe la prima della classe, ma spesso la vedo con gli occhi sognare spazi aperti e campi ricoperti di margherite ed elicriso.- E a casa erano rimproveri a non finire. Mi piaceva sognare a occhi aperti e poi amavo fiori e uccelli, perché era stato mio padre a trasmettermi quest’amore.
Dunque ero dinnanzi alla cancellata di ferro luccicante e imponente al fianco di mio padre. Tremavo come una foglia agitata dal vento di scirocco che seccava la gola d’estate, mentre lui era imperturbabile e sereno come se il latrato furioso dei cani fosse musica celestiale. Mi domandavo come faceva a rimanere così calmo senza tradire la minima emozione.
– Elisa – disse leggendomi il pensiero – tu hai paura e ne avrai ancora di più quando vedrai Billo e Billa, due cagnacci neri più alti di te. Se stai calma e serena, non ti faranno nulla, ma se tremi aprono le fauci e zac sparisci. –
Questo mi fece tremare ancora di più. I denti sembravano impazziti. Battevano rumorosamente tra loro in un fremito incontrollato, impedendomi di fare uscire le parole, mentre la cancellata si muoveva cigolando in silenzioso mossa da una mano misteriosa, e vidi i loro musi spuntare dalla fessura.
Smisi di tremare perché ero diventata di marmo e loro non abbaiavano più. Mi feci coraggio raccogliendo tutte le forze che non erano fuggite giù per la collina e seguì mio padre all’interno.
Tutto era smisurato dagli alberi ai fiori compresi cani e servitore che ci avevano aperto e accolto gelidamente.
– Oh! – era tutto quello che ero riuscita a dire mentre cautamente mi appiccicai alle gambe di mio padre. I due cani sembravano soddisfatti, ma erano in attesa di balzarmi addosso se solo avessi accennato ad aver paura.
Mio padre con fare sicuro si avvicinò a una casetta minuscola rispetto alla villa che si stagliava imponente al termine di un ripido sentiero e cominciò a estrarre gli attrezzi per lavorare il giardino.
Mi domandavo come avrebbe potuto manovrare quella zappa che era alta tre volte la mia statura, che era di molto superiore alla media dei miei coetanei di dieci anni.
La prese con disinvoltura e cominciò a zappare un angolo dell’aiuola centrale dove fiorivano delle splendide rose vellutate rosse, grandi come una teste di bue.
Io a bocca aperta dallo stupore lo vedevo dare colpi vigorosi e precisi di zappa come se l’attrezzo fosse normale.
– Elisa – mi rimproverò mio padre – non stare lì impalata come una stoppia. Dati da fare, perché al tramonto dobbiamo avere sistemato il giardino se vogliamo tornare a casa sani e salvi. Prendi dalla casetta degli attrezzi il sarchio e comincia a sarchiare per togliere le erbacce intorno ai rosai. Però fa attenzione alle spine, che sono pericolose.-
Alla paura era subentrato lo stupore e la sorpresa, perché impugnando il lungo manico riuscivo a manovrare l’attrezzo con agilità e precisione.
Lavorai, sudai e sbuffai tutto il giorno senza posa sempre guardata a vista dai due cagnacci, che si erano accordati su come spartire il mio corpo. Billo avrebbe preso la parte superiore, Billa quella inferiore. Non potevo e non dovevo scompormi, perché erano subito lì pronti a saltarmi addosso. Non sentivo la fame e la sete, perché la tremarella li avevano scacciati, come la fame aveva allontanato il lupo dal bosco. Il sole stava tramontando dietro quell’orrenda casa tutti merli e torrioni appuntiti e dovevamo sbrigarci.
Finalmente dall’enorme uscio uscì Gianantonio Lorchitruci, alto come un palazzo a tre piani, che guardò il lavoro che avevamo fatto e disse soddisfatto ma amareggiato: – Anche stavolta dovrò rinunciare alla cena serale. Prendi questi due zecchini d’oro e arrivederci al prossimo mese. –
Non vedevo l’ora di lasciarmi alle spalle quell’orrenda cancellata e correre a perdifiato lungo la discesa verso casa.
Mi svegliai col cuore in gola e col fiato corto come se avessi corso per mille miglia.
-Papà – dissi con un filo di voce – da oggi metto la testa a posto e non prenderò mai più un brutto voto a scuola. È centomila volte meglio andare a scuola con profitto che lavorare con te dai Lorchitruci. –
Mio padre sorrise accarezzandomi i capelli biondi e spettinati.